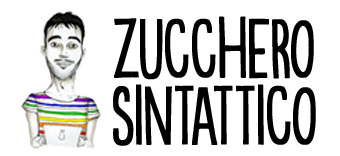Vedete, a me non interessa così tanto di chi sia la colpa. Ho già letto una marea di opinioni di giornalisti, influencer e amici di facebook che tentano di scaricare la colpa su qualcuno. Su Malika Chalhy, sui suoi agenti, sul mondo dello spettacolo o della stampa, sull’incapacità di gestire la popolarità, il denaro o l’improvvisa elezione a simbolo contro l’omofobia (immagino serva esperienza, e a 22 anni non tutti sono pronti).
Quello che mi interessa davvero è capire cosa “noi, la gente” possiamo imparare da tutta questa faccenda.
Secondo me c’è una grande verità da cui possiamo partire, con un briciolo di vergogna: creare raccolte fondi ad personam può essere molto pericoloso. E anche: donare a una sola persona tramite una raccolta fondi, anche se è appurato che quella sola persona è stata vittima di discriminazione, può essere molto pericoloso.
Il minimo che può succedere è che questa persona usi quei soldi per comprarsi una Mercedes. E perché non avrebbe dovuto farlo? Quei soldi sono effettivamente suoi, tu hai donato leggendo le condizioni del beneficiario. Ti aspettavi che ci avrebbe pagato lo psicologo, certo, così era stato dichiarato. Ma le due raccolte fondi organizzate per questa ragazza hanno raggiunto un totale di 150mila euro, e senza voler offendere nessuno penso che fosse facile intuire un probabile, cospicuo avanzo. Quell’avanzo appartiene al beneficiario, non c’è niente da discutere.
Ma la Mercedes è la conseguenza migliore. Ne intravedo una più a lungo termine, e molto più pericolosa, e si tratta della creazione di un precedente per cui a essere premiata con tantissimi soldi è stata la persona che ha saputo raccontare meglio il suo dramma. Quella che, per sua fortuna o suo malgrado, è finita in un gigantesco caso mediatico di cui ha parlato chiunque. Non ha vinto la solidarietà, non ha vinto la compassione: ha vinto lo storytelling. Una raccolta fondi ad personam è pericolosa perché trasmette il messaggio che per essere meritevole di così tanta solidarietà tu debba avere una bella storia, e saperla raccontare.
È giusto? No, è marketing.
Malika Chalhy non è un caso isolato. Ci sono decine di persone, in Italia, che ogni anno vengono cacciate di casa perché LGBT, ma solo una ha ricevuto 150mila euro per questo. Le altre non sono finite nel mirino dei media, perciò hanno ricevuto un trattamento diverso, che possiamo tranquillamente riassumere in: sono rimaste invisibili.
Invisibili non per chiunque, perché esistono delle associazioni che si occupano esattamente di questo: fornire un tetto a chi è stato cacciato di casa in quanto omosessuale, bisessuale o transgender.
Farò alcuni esempi, ma mi piacerebbe allungare questa lista, per cui vi invito a segnalarmi le realtà associative di questo tipo che conoscete:
- ToHousing, a Torino, a cui faccio ogni anno una piccola donazione tramite i ricavi del Checcalendario
- Refuge LGBT, a Roma, che recentemente rischia di chiudere
- Casa Marcella, in Toscana, che sta nascendo proprio in questi giorni grazie a una raccolta fondi, per le persone transgender
- Casa Arcobaleno, a Milano
Sono case rifugio gestite da associazioni regolamentate, e pensate un po’: hanno tutte bisogno di soldi. Dentro ci lavorano persone che hanno dedicato il proprio tempo a questi progetti, e ci vivono ragazze e ragazzi LGBT che altrimenti non avrebbero una casa. Cifre come 150mila euro sarebbero certamente molto utili per la loro missione, ma nessuno è mai diventato un caso mediatico.
Per fortuna, ripeto: l’ultima cosa che deve succedere è che parta la gara al caso più tragico.
Ci tengo a precisare ancora una volta che questa responsabilità è nostra, non di Malika, non di chi racconta la sua storia. Siamo noi che decidiamo dove destinare i soldi che diamo in beneficenza, e capisco che sia naturale farci guidare dal cuore e dalla storia più commovente, ma quello che è giusto è ragionarci e donare non solo a chi ha bisogno, ma a chi ti assicura che quei soldi serviranno per quella missione.