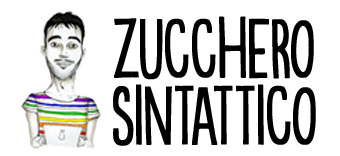Lettera aperta al me di novant’anni
/7 Commenti/in Me in bianco e nero/da Alessandro Bianchi


Agitare vigorosamente (o anche: non sono un food blogger se non si fosse capito)
/1 Commento/in Cose che penso/da Alessandro BianchiCi intestardiamo con ambizioni che vanno oltre la nostra portata. Mi riferisco – e lo specifico affinché evitiate di pensare che per una volta stia parlando di qualcosa di profondo, denso, o intellettualmente significativo – ai miei recenti obiettivi culinari. Perché io ho un sogno: l’alta pasticceria.
Dovete capirmi. Mia mamma è considerata la regina delle torte, e ha anche un grembiule che lo certifica; le mie nonne, essendo nonne, sono cuoche sapienti; e mia sorella, nonostante sia un po’ scema, sa preparare cheesecake, muffin e brownies dai tempi in cui io io riuscivo a malapena a spalmare la Nutella su una fetta di pane, a volte facendo cadere il coltello.
Tutto questo per dire che sono cresciuto con un profondo complesso di inferiorità che ho dovuto sublimare con altre competenze specifiche, come quella di saper collegare le stampanti o programmare la registrazione di Un medico in famiglia quando ancora esistevano le videocassette e soprattutto quando Un medico in famiglia non era il surreale puttanaio che è diventato oggi.
In un’Italia devota all’arte culinaria, il massimo che posso offrire è ascoltare i consigli di Simone Rugiati senza sbavare. Vaghiamo nell’oscurità più buia senza dire a nessuno di possedere un microonde. E così continuiamo a remare, dadi nella minestra, risospinti senza posa dentro il brodo.
Mi capita sovente di risolvere i miei drammi esistenziali ponendomi un quesito, che è: in questa situazione, cosa farebbe Beyoncé? Ora, credo che Beyoncé deleghi la questione del cucinare a dei prestanti chef stellati nudi e in catene, sempre che si nutra di vero cibo come noi umani e non di concetti astratti superfighi come, chessò, un panino al fascino, o uno sformato di splendosità.
Per cui, in questo caso mi domando cosa farebbe Benedetta Parodi.
E la risposta è: essere figa e iniziare dai preparati.
Inutile partire in quinta. Mio zio, comprendendo il mio dramma, mi fornisce strumenti utili alla mia istruzione. Mi ha già regalato, nell’ordine, un manuale di cucina low cost, un pentolino, uno sbattiuova e un minipimer, che sono sicuro prima o poi saprò padroneggiare.
Il vero dramma di questa società è l’inadeguatezza. Abbiamo bisogno di sentirci sicuri, tanto che spiattelliamo sui social la nostra versione migliore, illudendoci che se gli altri ci credono belli, ricchi e sereni, poi lo siamo davvero. L’altro giorno ho avuto un simpatico scambio di battute con i colleghi che dicevano che i fichi si mangiano con tutta la buccia, argomentando la loro versione dei fatti con acute motivazioni. Allora ho iniziato a mangiarli con la buccia. La sera stessa, alcuni miei amici mi hanno chiesto perché mai stessi mangiando dei fichi con la buccia, che a quanto ho capito è pregna di microbi, batteri, germi, Puffi ed ex membri degli One Direction. Tutto questo per dire che nemmeno sui fichi riesco a essere sicuro di me, figuriamoci sul resto.
Per questo bisogna partire dalle cose semplici. Come i preparati. In un posto che non nominerò per evitare di fare pubblicità ma che in breve sarebbe una multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili dai nomi buffi, ho trovato il preparato per fare i muffin. E davvero: non c’è da fare niente. Bisogna solo agitare la scatola vigorosamente e infornare. Le istruzioni sulla scatola usano proprio questo termine: vigore.
Il mio coinquilino colombiano ha voluto filmarmi mentre cercavo di mettere in pratica le istruzioni riportate sulla scatola della multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili da montare da soli seguendo un manualetto privo di testo il più delle volte incomprensibile. Ora, pubblico il video per giustificare la dicitura “blog multimediale” nel curriculum, voi però chiudete un occhio sulla mia raffinata mise, sull’acquaio pieno di piatti sporchi, sul calendario di Paperinik appeso alla parete, sul design squisitamente anni 80 della cucina e su un miliardo di altre cose di cui mi pentirò di aver messo online.
La verità è che per essere sicuri non serve chissà quale ingrediente segreto, così come non c’è da aggiungere niente al preparato per muffin della multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili in cui siamo soliti rubare lapis e metri di carta. Serve solo vigore.
Serve solo vigore, convinzione, energia, decisione, quel tanto che serve per poter mangiare i fichi come caspio ti pare, quel tanto che basta per avanzare proposte in cui si crede un giorno sì e uno no. Agitare vigorosamente e infornare, e se i muffin vengono acciaccati, storti, tristi, brutti e al sapore di legno, beh: alzi le spalle e vai avanti con la prossima idea.
La prossima, sbiadita, idea.
Disagio
/4 Commenti/in Cose che penso/da Alessandro BianchiPer fortuna che ci sono io, che esprimo la mia irrilevante opinione con cognizione di causa.
Bisogna che vi dica una cosa riguardo allo spot: è stato diretto da Pupi Avati. Un Pupi Avati chiaramente devastato dalla demenza senile, oppure il suo apprendista scemo. Il video comincia con un bambino vestito come in una qualsiasi fiction Rai che corre tra i binari.
È in ritardo, tutti i suoi amichetti sono già arrivati e lo salutano gioiosamente, ignari del fatto di essere con tutta probabilità diretti verso un campo di concentramento.
Il bambino li guarda. È evidente che stia mentalmente smoccolando in aramaico.
Ma attenzione, perché silenzioso come un ninja d’acciaio arriva da dietro il prestigioso Frecciarossa 1000.
Ora, parliamone: perché l’hanno chiamato Frecciarossa 1000? Perché 1000? Frecciarossa 100 sarebbe stato un richiamo troppo evidente a Iva Zanicchi, d’accordo, ma perché 1000 e non 2000? O non 3000, come Novella 3000. Non è una domanda così scontata. Inserire nel nome di un nuovo modello di un treno il numero 1000 mi fa immediatamente pensare a quella logica che andava tanto di moda negli anni Novanta, quando si aggiungeva sempre un numero in più, e poi uno zero, ma è un meccanismo che adesso suona arretrato, ridicolo, vecchio. Provoca lo stesso effetto di quei cinquantenni che vanno nelle discoteche coi pantaloni a zampa di elefante zebrati.
Ho sempre pensato, e lo vorrei pensare ancora, che la stazione sia uno dei posti più belli del mondo. Sarà perché lo ricollego a dei momenti speciali della mia vita, ma non mi vengono in mente dei luoghi con quel preciso, specifico romanticismo, quella densità di nostalgia, quel brulicare di umanità. Trenitalia, davvero: cosa stai facendo? Stai togliendo la poesia all’immaginario della stazione, e te ne vanti. Certo, te ne vanti. È un preciso intento quello di trasformare il treno in una macchina futurista, un serpentone aerodinamico che riluce di rosso e bianco, un’astronave; altrimenti, perché permettere questo spot in cui il contrasto tra il passato e il futuro è così evidente?
Ma il video sta andando avanti. Le porte si aprono da sole.
Il bambino sale, e nelle inquadrature successive noi possiamo ammirare quanto sia pulito il treno, una lucentezza che molto probabilmente è stata aggiunta in post-produzione perché io quando ci sono salito non ho avuto l’impressione di trovarmi sull’astronave di Mastro Lindo.
Il giovane criptoebreo continua a esplorare il mezzo, che grazie al formato cinemascope del video sembra che abbia una larghezza sconfinata, e incontra l’unica dipendente gentile di Trenitalia. O forse è un’attrice.
Il bambino solleva lo sguardo, e uno potrebbe pensare che stia di nuovo imprecando contro Dio perché si è appena reso conto che un posto su quel treno costa 100 euro, oppure che abbia sentito uno di quei simpatici messaggi acustici che danno regolarmente sulle Frecce che neanche Spotify, oppure che stia controllando come mai l’aria condizionata non funzioni.
E invece il bambino solleva lo sguardo perché è meravigliato.
Io me lo ricordo bene, un bambino meravigliato dai treni. Mi ricordo come conosceva a memoria tutte le parti che lo componevano, come poteva stare un’ora intera alla stazione a guardarli passare, indicandoli col ditino e ricercando il tuo sguardo per controllare che anche tu provassi la stessa emozione. Quel bambino non sarebbe di certo stato attratto dalle luci del soffitto, o dalla classe Business con la sala riunione, o dal wifi.
E alla fine del tunnel, vediamo lo schienale di una poltrona ruotare, in perfetto stile da cattivone di telefilm anni Ottanta. E invece a sedere nella cabina di comando c’è un modello di intimo vestito da capotreno, che sorridendo inquietantemente lo invita in quella stanzina – proprio come avrebbe fatto un cattivone di un telefilm anni Ottanta. “Vuoi che li raggiungiamo?” chiede al piccolo, come se fosse alla guida di un taxi.
“No, non voglio scendere mai più”, replica il bimbo.
Un cretino di bambino, diciamo.
Avrei voluto esporre tutto questo al vecchietto della stazione, quello pagato per passare l’intera giornata al banco di Frecciarossa per non fare niente. Quando ho osato chiedere informazioni, mi ha chiesto di aspettare che finisse la conversazione con il suo amico, per favore. “Certo”, ho risposto io, che in fondo ho un animo gentile e ci tengo all’educazione.
Mi ha detto che non sapeva se mi convenisse l’abbonamento o il carnet. Io, che ero dunque più informato di lui, ho risposto che poiché le offerte per i pendolari sono inesistenti, l’unica maniera per spostarmi era pagare il prezzo esorbitante dell’abbonamento. A quel punto, il loquace signore ha detto che noi giovani non vogliamo svegliarci presto, altrimenti pagheremmo meno.
Perché? Perché uno sconosciuto si dovrebbe permettere di dirmi una cosa del genere? Perché una persona appartenente a una generazione che non ha di certo dimostrato di tenerci al futuro dei suoi figli, dovrebbe arrogarsi il diritto di conoscere la mia situazione, quella di tutti i miei coetanei e arrivare perfino criticarla?
A me non è mai piaciuta questa moda di criticare i giovani. Pensano che non sappiamo pensare, stare al mondo, preoccuparci delle cose, pensano che non sappiamo faticare.
Ho lasciato la stazione con dentro un senso di amarezza, mentre una voce molto familiare si scusava per il disagio.