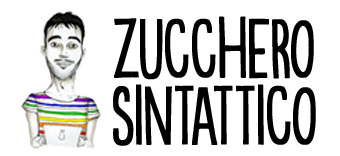Il fatto che riesca a ricordare soltanto gli incubi e mai i sogni dovrebbe dare un’idea abbastanza precisa della mia personalità senza aver bisogno di consultare un luminare della psicologia. Quando mi sveglio non ho alcuna memoria di ciò che ho appena sognato e, secondo una rapida ricerca in rete che sconsiglio di effettuare a chi ha il mio stesso problema a meno che non voglia sentirsi un egocentrico e superficiale pezzo di merda, ciò è dovuto probabilmente a una scarsa attenzione per il mondo interiore, insieme a un pesante controllo su sé stessi e a troppa razionalità, oppure a ciò che da quando è iniziato il ventunesimo secolo siamo abituati a utilizzare come giustificazione di ogni nostro comportamento da stronzi, e cioè: “un periodo di forte stress”.
Essendo io molto stressato, succede che dimentico sempre il mio percorso onirico, ed è un peccato perché sono molto attento al mondo interiore, non tendo ad avere un ossessivo controllo su me stesso e sono razionale nella giusta misura, oltre che carino, simpatico ed estremamente intelligente.
Non biasimatemi, dunque, se per una volta che mi sveglio e mi ricordo alla perfezione ciò che ho appena sognato, annaspo con la mano sul comodino alla ricerca del cellulare e mi sbrigo a trascrivere tutti gli avvenimenti prodotti dal mio inconscio; e non biasimatemi se nelle successive due ore ho ammorbato svariati amici con la descrizione del mio incubo; e nemmeno dovreste biasimarmi se uso questo spazio per raccontarlo anche a voi. D’altronde, non mi capita spesso di sognare. E poi, be’, ho sognato Gianni Morandi.
Il sogno inizia in medias res, che è una formula che noi tutti impariamo in prima media senza che poi abbiamo mai occasione di usarla all’infuori della verifica di italiano. Mi trovo in montagna nel cottage di Gianni Morandi e della sua famiglia, e se vi state chiedendo come possa io esservi finito dovete mettervi l’animo in pace perché questo è un punto che non sono riuscito a chiarire nonostante il certosino lavoro di scavo operato sul mio povero inconscio.
Insieme a me, nel cottage di Gianni Morandi c’è il mio amico Ciuffo, che per chi non lo conoscesse è un ragazzo molto simpatico dalla testa tonda e dagli occhi grandi e sinceri, che un tempo aveva un pugno di capelli che svirgolavano verso l’alto conferendogli il soprannome con cui ancora oggi lo chiamano gli amici e perfino una considerevole parte di parentame.
Il buon vecchio Gianni Morandi è un ottimo padrone di casa. Ci accoglie con grandi sorrisi e parole ospitali. A un certo punto, apre un portone che dà niente meno che su una discesa di neve. Senza interrogarsi sul perché Gianni Morandi dovrebbe avere una pista per slittini in casa, il mio amico Ciuffo afferra un bob lì vicino e si getta tutto contento; io, che sono notoriamente più palloso, ringrazio Gianni Morandi dell’occasione ma gli comunico che soffro di vertigini e che pertanto non usufruirò della discesa.
«Ma ti prego, Alessandro, dobbiamo arrivare a valle. C’è una sorpresa per voi!» esclama Gianni Morandi con la sua famigerata solarità.
«E va bene, Gianni Morandi, verrò a piedi.»
Una volta a valle, tuttavia, vedo qualcosa di strano. Proprio al limitare della discesa, una decina di sbarre emergono dalla neve. Guardando meglio, vedo che oltre le sbarre c’è il mio amico Ciuffo, evidentemente in stato confusionale. Sono perplesso. Mi volto verso Gianni Morandi per chiedergli se sapesse cosa stava succedendo.
«Gianni Morandi, cosa sta succedendo?»
Nel suo sguardo non c’è più traccia di sorriso. Alcune nervose imperfezioni del fondotinta rivelano delle rughe minacciose che gli rendono il volto vecchio e cattivo. I suoi occhi sono ridotti a fessure.
«Prendetelo» ordina Gianni Morandi, nella sua versione da malvagio dei telefilm anni Ottanta da cui sono evidentemente influenzato altrimenti non sognerei battute di dialogo così tamarre. Il punto è che mi ritrovo accerchiato da omoni nerboruti che mi prendono e mi gettano nella gabbia dove già si trova il mio amico Ciuffo.
La gabbia è circolare – un chiaro tributo del mio inconscio all’ultimo video di Sia – e Gianni Morandi ci guarda attraverso le sbarre. Non è solo: accanto a lui c’è il figlio Marco Morandi. Marco Morandi e Gianni Morandi ci guardano con un misto di serietà e perfida soddisfazione.
«Hai visto, figliolino? Li ho catturati…» dice Gianni Morandi.
«Sei stato bravissimo, papà» risponde Marco Morandi.
Io e il mio amico Ciuffo chiediamo spiegazioni, poi cerchiamo aiuto, ci disperiamo, urliamo, ma invano. Non c’è nessuno nei paraggi, ad eccezione dei due componenti della famiglia Morandi che ci fissano per tutto il tempo.
«Adesso ci divertiamo un po’» dice Gianni Morandi, quando finiamo di gridare. La sua voce fa paura.
I Morandi inseriscono nella gabbia, uno per volta, una quindicina di pavoni. Il mio inconscio deve aver letto da qualche parte che i pavoni possono essere degli animali estremamente aggressivi. Ad ogni modo, gli uccelli incattiviti iniziano a rincorrere me e il mio amico Ciuffo, che piangiamo, gridiamo, e infine, stremati, ci offriamo ai pavoni per farla finita il prima possibile.
È a quel punto che Marco Morandi pone fine alla tortura.
«E adesso papà devi corromperli.»
Okay, non ha senso, ma comunque dopo averci fatto rincorrere da pavoni imbizzarriti, i due Morandi ci liberano e ci promettono una quantità esorbitante di denaro in cambio del nostro silenzio.
«Ma quale silenzio, io vi denuncio sul mio blog!» replico io, senza alcuna logica, e proseguo argomentando: «Si chiama Zucchero Sintattico, e racconto i miei pensieri cercando di essere ironico ma offrendo talvolta interessanti spunti di riflessione, per esemp…»
«Infatti!» mi dà manforte il mio amico Ciuffo «e mettete anche il Mi piace alla sua pagina facebook, è molto simpatica!»
«Hai già raccontato dell’incidente?» mi chiede Gianni Morandi, che d’un tratto si è fatto preoccupato.
«Che incidente?»
«Papà, dannazione, ci siamo sbagliati, non sono loro i testimoni oculari del terribile incidente che ho provocato quando la notte scorsa guidando ubriaco ho investito due passanti innocenti dunque è del tutto inutile torturarli e cercare di corromperli in cambio del loro silenzio» conclude Marco Morandi, dando prova che perfino i miei sogni sono didascalici.
All’improvviso, una figura femminile sbuca da dietro un albero. È Taylor Swift, e ha una chitarra.
«Siete spacciati, Morandi: ho già inciso una canzone con la mia casa discografica in cui racconto il misfatto» dice Taylor, tra l’altro un’affermazione del tutto fantascientifica considerando che i testi della sua discografia riguardano amori finiti e irrecuperabili. «Da domani sarà prima sulle classifiche di iTunes, e per voi sarà la fine. Liberate subito Ale e il suo amico Ciuffo!»
Dopodiché mi sveglio, con la sensazione che qualcosa non torni e che, in un certo senso, sia meraviglioso così.