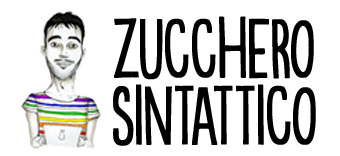La mia vita, più o meno.
Felicità vera
/4 Commenti/in Cose che mi succedono, Cose che penso/da Alessandro BianchiAlla ricerca della lampadina perduta*
/6 Commenti/in Cose che mi succedono, Cose che penso/da Alessandro BianchiUna storia su di me che vorrei raccontare di nuovo perché ora l’ho capita
/11 Commenti/in Cose che mi succedono/da Alessandro BianchiLa classe di Paperoga
/13 Commenti/in Cose che mi succedono, Cose che penso/da Alessandro BianchiAggiornamenti vari senza titolo simpatico
/15 Commenti/in Cose che mi succedono/da Alessandro Bianchi– una persona a cui voglio tanto bene sta un pochino meglio e la andrò a trovare presto
– sapere che Alice Rohrwacher, che ha fatto la mia stessa scuola, ha vinto il Grand Prix al festival di Cannes
– per puro spirito culinario e scientifico ho sperimentato la pomodonara (marchio registrato da me), cioè la carbonara coi pomodorini al posto della pancetta, e ho scoperto che è praticamente un orgasmo
(se questo post inspiegabilmente vi dovesse suggerire vignette o disegnini, mandatemeli che li posto molto volentieri!)
Va tutto bene
/12 Commenti/in Cose che mi succedono/da Alessandro BianchiCose insolite a cui la gente non crede se gliele racconto
/22 Commenti/in Cose che mi succedono/da Alessandro BianchiTempo di buoni propositi
/15 Commenti/in Auguri virtuali, Cose che mi succedono/da Alessandro BianchiMi sono avvicinato alla macchinetta del caffè, parlando con U di malattie veneree – è tradizione che quando siamo in pausa affrontiamo questo genere di argomenti così mettiamo paura agli altri e rimaniamo soli per sempre come piace tanto la vita a noi. Ho selezionato il mio cappuccino con cinque pallini di zucchero (una mia amica non mi considera uomo per questa cosa: la zuccherofobia è la nuova frontiera della discriminazione). Il problema è che, tra una battuta sulla gonorrea e una sulla clamidia, ho premuto il tasto finale troppo tardi, e i pallini di zucchero si sono azzerati.
Mi sono voltato verso U con uno sguardo che lo implorava di mettere fine alle mie sofferenze.
– Ti prego, strangolami.
– Oh, Ale. È così: se aspetti troppo, la vita diventa più amara. Scusa, dovevi dirlo tu, vero?
Sì, avrei dovuto dirlo io, perché sono io quello che scova le conclusioni filosofiche nelle idiozie. A ogni modo, il mio proposito per il duemilaquattordici mi viene suggerito da un cappuccino non zuccherato.
Buon anno a tutti. E non aspettate troppo.
Il treno che passa da Magenta
/20 Commenti/in Cose che mi succedono/da Alessandro BianchiSono immerso in questi pensieri quando mi accorgo di essere arrivato a Magenta. Alzo la testa e mi guardo intorno. Davanti a me c’è una famiglia di sordomuti in piena crisi. Ti accorgi quando dei sordomuti stanno litigando perché stanno zitti, ma smanaccano convulsamente e hanno la faccia tutta contrariata. È un po’ come guardare Dragonball senza audio.
Alla mia destra c’è una vecchietta con un paio di fantastici stivali da pioggia e nessun dente. Accanto a lei un signore di quarant’anni che legge Geronimo Stilton e il galeone dei gatti pirati. No vabbè è il treno del disagio. Poi per forza uno è sfigato, me la passate per osmosi.
Riflettendoci meglio, ho capito che quel tipo, quello che legge Geronimo Stilton è un grande. Guardandolo, ho intuito che probabilmente è straniero. Magari non è più nel suo Paese e deve imparare una nuova lingua, e lo fa iniziando dai libri per bambini. O magari vuole insegnare a leggere al figlio, e prima di farlo deve fare esercizio. Quel tipo che legge Geronimo Stilton è un grande perché ci vuole tanta forza di volontà per migliorare. Più che il talento, più che l’intelligenza. Non ha perso tempo a pensare che non sa l’italiano: sta cercando di impararlo e basta.
La conclusione – esplicitata in perfetto stile Disney, non è che vi considero cretini, è che ho bisogno di metterla nero su bianco – è che una volta che ho preso atto della mia scarsa cultura, devo cercare di digievolvermi dallo stadio di capra e recuperare le tappe che mi mancano. I francesi hanno un’espressione che rende tantissimo, che è farsi il culo.
Così, apro lo zaino e tiro fuori Salinger e inizio a leggere.