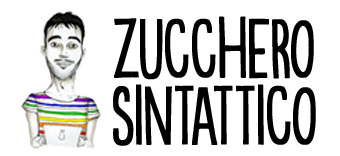Sì, tutto bene. Sono sul treno adesso. Tranquillo, posso parlare. No, non sono solo nel vagone: c’è un’unica italiana sulla quale eviterò ovviamente di fare considerazioni, ma per il resto la compagnia è composta da due americane delicate come la contessa De Blanck e una giapponese che incarna perfettamente lo spirito della giapponesità: ringrazia unendo le mani a preghiera e facendo un mezzo inchino con la testa. E ovviamente sorride. Mi ricorda un po’ una versione meno idiota di me. Niente in confronto col viaggio di andata, comunque: ero su un intercity Salerno – Torino pieno zeppo di napoletani agitati. Nulla contro i napoletani, ma tendono a interagire urlando.
Sì, Torino è favolosa. Orientarsi è semplicissimo, è un reticolato di strade, cioè le vie sono fatte tipo le calze di Rihanna, quelle a maglia larga per intenderci. Le piazze sono enormi, i palazzi alti. Si respira l’aria di una grande città, ma senza tutto il caos di Milano o di Roma. È come se tu non fossi obbligato ad avere una vita frenetica, nonostante la città lo permetta. E anche i torinesi mi piacciono: mi erano stati descritti come degli italiani freddi, e invece ovunque andassi ho trovato scherzi e sorrisi.
Casa mia? È in pieno centro, è vicina a tutto. La posizione è eccezionale, l’altra sera sono sceso e mi sono trovato in mezzo a un concerto. I miei coinquilini sono dei ganzi – uno è della Valle D’Aosta e appiccica adesivi di baffi ovunque, e l’altro è di Bolzano e parla tutto buffo, sì, praticamente io sono il terrone della casa. La mia stanza è fantastica. Sì, lo so, ho esaurito gli aggettivi a connotazione positiva e adesso mi tocca ripeterli. Oddio, diciamo che la mia mansardina è diventata un gioiello adesso che non sembra più l’ambientazione di un romanzo di Lovecraft. Ho passato due giorni a pulire tanto che adesso trasudo Lysoform. Sì, ho pulito col Lysoform. Sarebbe stato più utile il Necronomicon, te lo dico io.
L’unico problema della camera è che non va la luce, ma ho risolto comprando una abat jour. Ma te lo sapevi che esistono diversi tipi di lampadine? Sono andato a comprarla, e il commesso mi ha chiesto se ne volevo una grande o piccola. Grande, dico io, ché nel dubbio uno punta sulle dimensioni. Ma è chiaro che invece ci voleva quella piccola: tutto l’universo cospira affinché tu faccia la scelta sbagliata quando hai il cinquanta per cento di probabilità di fare quella giusta.
L’inaugurazione della Holden è stata quanto di più figo ci si possa immaginare. C’era la musica, i fuochi d’artificio, i giochi di luce, i palloni giganti, mancava giusto Regina Miami ma insomma c’era Baricco, direi che ci può stare. Ti rendi conto che negli ultimi anni sono andato a ballare in continuazione e che la festa migliore a cui abbia mai partecipato sia stata organizzata da una scuola di scrittura? Hanno capito tutto, sti intellettuali. C’avevano pure il vino senza solstizi. No, solfeggi. No, no, solfiti, il vino senza solfiti, che significa che lo puoi bere e il giorno dopo non c’hai il mal di testa. Hanno capito tutto ti dico, gli fa una sega Paris Hilton a sti qua.
Sono quasi a Genova, ci sono le gallerie tra poco. Torno giù per qualche giorno, il tempo di salutare tutti e di sbrigare le ultime cose e poi riparto stabilmente. Mi mancherete un sacco sai? Sarà proprio tutto diverso senza di voi, senza cenare con la mia famiglia e litigare sul fatto che ho troppe paia di Converse tarocche, senza le prove di martedì, che sono l’unico momento in cui mi concentro, che sono il mondo di persone con cui sto bene, senza tutti quei rituali televisivi da guardare insieme al mio amico e a mia sorella, senza i messaggini su cosa fare il sabato sera, senza la mia famiglia, senza i miei amici, senza tutto il resto.
Ma devo partire, capisci? E non perché a Lucca non c’è niente, e nemmeno perché giù non trovo lavoro. E sai, forse non è nemmeno perché scrivere è la mia vita, perché certo che lo è, ma sai, se uno vuole scrivere scrive, sulla carta igienica piuttosto, sui muri, sul retro dei francobolli, sui sassi con altri sassi, se uno vuole scrivere scrive e gli va bene qualsiasi posto, ma io non lo so se è per quello. È tutto un pretesto per dimenticare, ho questa urgenza, quella di dimenticare. Non lo so se è un discorso a cazzo, ma te lo dico: a un certo punto bisogna distruggere, prima di costruire. E io ho un mucchio bisogno di questo, di distruggere e ricominciare a costruire qualcosa di mio, senza fantasmi a violentarmi la mente, e questa è l’opportunità che ho per farlo, e vediamo come va, e mi mancheranno tanto le cene le Converse le prove guardare la tv insieme i messaggini tutto il resto ma sarà bello, per una volta, per qualche tempo, sentire la mancanza per qualcosa, sentire solo quella mancanza, la mancanza di qualcosa che invece c’è, e non la mancanza di qualcosa che effettivamente non esiste.
Non mi hai capito, vero? Sono troppo contorto. Mi dici di sì ma in realtà mi lasci solo sfogare, o forse non senti niente per via delle gallerie. In ogni caso ascolta, quello che assolutamente evitare nella vita è lasciarti tentare dalla pasta Combino della Lidl: costa poco, okay, ma fa schifo.